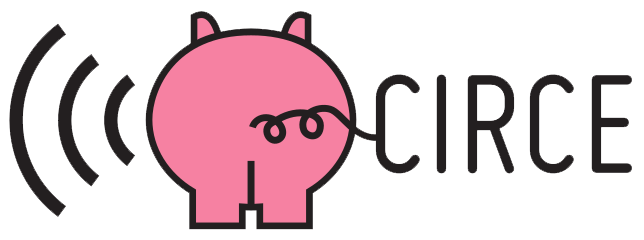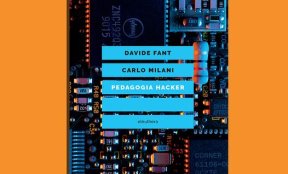TL;DR (Too Long; Didn't Read)
Lo pseudo-libro Ipnocrazia è robaccia che offre l'occasione per stroncare non solo un elenco di lettere messe in fila a stampa con il ricorso a un LLM, ma anche un modo di fare deleterio dell'industria culturale, che rivela estrema noncuranza nei confronti di chi legge e del mondo condiviso in cui viviamo.
Dell'arte di stroncare
Vi fu un tempo in cui si stroncavano libri, film, spettacoli. Stroncare è verbo metaforico: estende il significato originario di troncare in maniera violenta; significa quindi spezzare, demolire.
Non ho mai avuto la fortuna di subire una stroncatura in piena regola. Fortuna, dico, perché mi son sempre immaginato che la critica segua la lettura, nel caso dei libri, così come l'aver assistito a un'esibizione nel caso di uno spettacolo. Una stroncatura significherebbe dunque una lettura più o meno attenta, o, quanto meno, critica. Ma oggigiorno la superfetazione merceologica anche libresca è talmente sovrabbondante da intimorire, fino a scoraggiare, la scelta di un bersaglio critico; e perché poi affaticarsi, se, in fondo, come ricorda Lord Henry al principio de Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, "there is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about"? (in italiano, è entrata nell'uso comune la traduzione assai infedele "bene o male, l'importante è che se ne parli").
Nonostante queste considerazioni, ritengo che in questo caso ne valga la pena. Perché non si tratta solo di stroncare un libercolo, ma un intero sistema di intendere e praticare la cultura; una modalità pervasiva di occupare la sfera mediatica; un insieme di comportamenti per cui si "usano" degli "strumenti" per raggiungere i propri scopi, per veicolare i propri "contenuti", o mettere in opera le proprie operazioni "culturali" con molte complicità attorno. Il buon vecchio Gianfranco Marelli, mi ricorda un amico e collega, l'avrebbe probabilmente definito "lo spettacolo della critica": un insieme di attività sostanzialmente integrate nell'establishment, ma con presunzione di radicalità.
Il ricorso alle virgolette, quando non indica una citazione o non è seguito da traduzione, sottolinea un uso improprio di un termine. Gli strumenti infatti non sono oggetti che i soggetti umani semplicemente usano: si strutturano insieme agli umani in relazioni di senso nel quadro di un mondo condiviso.
L'oggetto-libro diventa quindi occasione di riflettere sul soggetto-che-legge, ammesso che esista ancora, per poi estendere lo sguardo all'industria culturale, allo spettacolo, all'intrattenimento, alla formazione.
Oggetto di stroncature è "Ipnocrazia", edito da Tlon. Brossura che mi è stata passata da un caro amico: "dagli un'occhiata", mi ha detto. L'ho soppesata, odorata, sfogliata, leggiucchiata in diagonale, e ho risposto: "robaccia". Confermo. Una lettura più dannosa e nociva che inutile.
Com'è possibile formulare un giudizio in pochi minuti senza un'attenta disamina e lettura completa? Analogamente a quel che accade con il cibo: non è necessario sbafarsi un'intera porzione di pastasciutta stracotta e troppo sapida per concludere in maniera inappellabile che è un pessimo piatto. Dal momento che mi son passati fra le mani migliaia di volumi, in particolare saggi, ho imparato a formarmi un giudizio rapidamente. Ars longa, vita brevis: non è il caso di perder tempo appresso a libri che non merita attenzione.
Certo, è sempre possibile sbagliarsi. In seguito a numerose recensioni e articoli, irritato dall'attenzione risvegliata da questa pubblicazione, ho effettuato un'osservazione più approfondita. Ri-confermo: robaccia. Aggiungo: robaccia la cui stesura ha comportato uno spreco favoloso di risorse energetiche, perché messa in atto con la cosiddetta "IA" (che, ricordiamo, non esiste, nel senso che non è né Intelligente, né Artificiale, bensì involucro e imballaggio privo di contenuto, prossima al cavaliere inesistente di Calvino, secondo l'allegoria di S. B. Barale, L'Intelligenza inesistente, Altreconomia, 2024). Non starò a tediarvi con tecnicismi: rimando chi volesse comprendere come si poteva scoprire senza sforzi straordinari che si tratta di un insieme di caratteri a stampa messi insieme con un LLM (Large Language Model) di tipo GPT (Generative Pre-Trained Transformer) al post relativo sulla lista NEXA del Politecnico di Torino.
Il contesto culturale
A mio avviso, un libro ha senso se c'è chi lo legge, oltre a chi lo concepisce, scrive, revisiona, corregge, stampa, pubblica, promuove, distribuisce, traduce, critica e discute. Oppure rimane un regalo che chi scrive dedica a sé, come avviene per i diari privati (che, però, è talvolta magnifico leggere: l'archivio diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano offre tantissimi esemplari del genere). Nel mondo attuale, ad alta intensità tecnologica, subentra l'elemento tecnico in maniera ancora più rilevante rispetto alle tecnologie di stampa e distribuzione; per questo è tanto più necessario dismettere uno sguardo ingenuo, naturalistico.
Attivare uno sguardo obliquo, come quello che proponiamo nelle nostre attività e attivazioni di pedagogia hacker, è una possibilità. Un atteggiamento fenomenologico, nel senso ampio di situato e incorporato, per osservare in maniera non superficiale il mondo. Per non farsi ingranaggi nelle Megamacchine contemporanee, mix di spettacolo, sfruttamento e stupidità.
L'oggetto-libro si inserisce in un'industria culturale che, in Italia, ha prodotto nel 2024 oltre sessantottomila nuove uscite, ristampe escluse (secondo l'AIE, Associazione Italiana Editori), per un pubblico potenziale di circa cinquanta milioni di persone in grado di leggere un testo in lingua italiana. La stragrande maggioranza di queste pubblicazioni sono pagate da autori e autrici, non di rado attraverso fondi accademici. "Libri" stampati in poche decine di esemplari, al massimo qualche centinaio: il loro destino è di non raggiungere mai gli scaffali di una libreria, né tanto meno le mani di una persona incuriosita dal titolo, dalla copertina, dalla quarta, dall'indice, dalla bibliografia, dalle note, dal testo. Questi sono, nell'ordine, gli elementi che personalmente valuto prima di mettermi a leggere un saggio.
D'altra parte bastano poche migliaia di copie vendute per entrare nelle classifiche di vendita, a dimostrazione di quanto la categoria "autore" sia affollata, al contrario della categoria di chi legge.
Compito dell'autore sarebbe far crescere, poiché auctor in latino deriva dal verbo augere, "accrescere". In senso proprio, gran parte dei libri attuali fanno crescere solo il mercato della stampa, distribuzione (logistica) e macero. Persino nel caso di un "miglior-vendita" (best-seller) da centomila copie (rarissima eventualità nell'italica lingua), il quale comporta con ogni probabilità trentamila copie di macero. Il trenta per cento di macero è infatti considerato un buon risultato in questa industria.
Ampliando lo sguardo, osserviamo che attorno al libro prolifera, senza prosperare, tutta un'industria di pubblicità, favori, recensioni, presentazioni, promozioni radio-televisive (forse le uniche in grado di smuovere le vendite), nonché festival culturali. Ottenere recensioni (e tanto più inviti ai festival) implica il lavoro di uffici stampa che fanno inviare decine di copie (gratuite) a chi scrive su giornali e riviste; campagne stampa, social, radiotelevisive e via dicendo; il lavoro di agenti che s'impegnano per ottenere la merce più rara e pregiata, ovvero l'attenzione del pubblico: quanto meno del pubblico degli addetti ai lavori.
Ipnocrazia ha ottenuto attenzione. Il giochino del (poi rivelatosi finto) autore cinese che scrive sulla confusione fra realtà e finzione e sull'eventualità di non esistere in quanto autore, attorcigliando lo pseudoragionamento sul "concetto" di "potere dell'ipnosi" in cui ci troveremmo a vivere... ha attirato l'attenzione di parecchi critici. Del tutto ignari, o noncuranti, dell'inesistenza del sedicente autore, avatar di un umano in carne e ossa che ha senz'altro passato del tempo a "disegnare per far succedere cose" (prompt design) davanti a qualche schermo connesso a un LLM di tipo GPT. Mi chiedo: questi augusti recensori, fini critici, intellettuali contemporanei, hanno letto il sedicente libro? L'hanno sfogliato? Mi auguro di no, come spesso accade: perché se l'hanno letto e non sono riusciti a pronunciare un semplice "robaccia", scritta male, ripetitiva, senza capo né coda, senza note, riferimenti, bibliografia (si spaccia per saggio), come lettori non valgono molto.
D'altra parte, se non l'hanno letto, perché hanno dedicato del tempo a scriverne, occupando una quantità non trascurabile di spazio sui giornali e sulle riviste, nonché tempo mentale di ulteriori umani a legger le loro riflessioni, messe in fila a partire da un "libro" ovvero da frasette ficcate in una finestrella per interagire con un LLM, ovvero da una serie di lanci di dadi per interagire con modelli statistici proprietà di multinazionali praticamente esentasse? (Le precedenti sono riformulazioni dell'espressione "prompt design").
Il contesto culturale è anche questo. Amici di amici, o amichetti di amichetti, sensibili e disponibili. Ammetto: non ho mai ottenuto grandi recensioni per ciò che ho scritto e pubblicato. Un po' meglio per le traduzioni, il che fa sempre piacere, visto il carattere niente affatto triviale dei saggi in questione. Ma non è questione d'invidia, è questione di contesto. Come funziona questo contesto? Cosa ci dice questo contesto?
Sono domande autentiche, per le quali non ho risposte preconfezionate. Lascio a voi. Mi permetto di esprimere ciò che non dice, ciò che non rivela, né rivelerà nemmeno dopo lo "svelamento", evidentemente programmato a tavolino, dell'"operazione culturale" avvenuta sulle pagine dell'Espresso. Non dice che per progettare e portare a termine un'operazione del genere non sarà sufficiente frequentare i corsi di "prompt design" (vedi sopra) che, non dubito, la solerte casa editrice del finto autore cinese proporrà quanto prima a folle di aspiranti autori. Indispensabile è invece la frequentazione delle persone giuste nei luoghi giusti, ovvero di chi scrive sui giornali, di chi suggerisce, produce, favorisce, organizza i corsi, i convegni, i festival, le ospitate radio-televisive e via discorrendo. Cioè la frequentazione di chi è intraneo all'industria culturale e può esercitarvi una qualche influenza. E con questa rivelazione dell'ennesimo segreto di Pulcinella, passo all'ultimo punto della stroncatura: quello relativo alla costruzione di una presunta genealogia nobile di questa "operazione culturale".
Lasciate stare Luther Blissett
Ho letto che questa raccolta di frasi rielaborate in maniera statistica (sempre il sedicente libro oggetto della stroncatura) si ispira, o, peggio ancora, è l'unico modo di omaggiare le beffe di Luther Blissett all'industria culturale. Queste osservazioni sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi ha convinto che valeva la pena impegnare buona parte di un tragitto Milano-Roma per scriverne.
Luther Blissett, ricordiamolo, fu esperienza policentrica, organizzata in maniera non gerarchia; coinvolse molte persone con sensibilità diverse nella stesura di comunicati, testi, libri, ecc. Espressioni di controcultura: cioè non interne all'industria culturale dominante. Le tantissime persone che decisero di rivendicare un'azione, uno scritto come Luther Blissett non necessariamente si conoscevano fra loro. Condividevano il rifiuto del copyright; inoltre, non gestivano case editrici e, per quanto ne so, non avevano contiguità con i pezzi grossi di giornali, riviste e TV. Erano mosse da generosità, sincero disgusto per il bolso imparruccamento conformista della cultura ufficiale, voglia di irriderla e sbeffeggiarla, perché una risata vi seppellirà, e se non lo farà, almeno si sarà riso noi, che non è poco. Così l'ho vissuta io, dall'esterno, da lettore e fiancheggiatore. Luther Blissett è stato anche autore dell'amato romanzo Q, e di altri saggi e opere, che pure ho letto con piacere.
Quelle scritture poliautoriali esprimevano posizioni anche conflittuali fra loro, ma nonostante questo erano accomunate da chiari posizionamenti politici, del tutto estranei al non-posizionamento di Ipnocrazia (o al suo conformismo mascherato da critica politica, se preferite). Altro punto in comune: un'inequivocabile, indiscutibile sforzo e tensione a dar vita a delle opere che possono piacere o meno, ma opere rimangono, da cui traspare impegno, dedizione, cura. Spesso anche una scrittura raffinata. Decisamente, NON robaccia. Nessuna genealogia comune con Ipnocrazia, nessuna filiazione, se non impropria e inadeguata, frutto probabilmente della volontà di spacciarsi come ribelli e sfrontati sinistroidi in un'epoca in cui la sinistra, nel senso di cultura e pratica dell'autogestione solidale, è ridotta al lumicino o non esiste più da un pezzo, di certo non a livello istituzionale e culturale.
Luther Blissett esercitò un influsso duraturo ben al di là delle opere prodotte e pubblicate. Per molti anni fu pratica condivisa, nei servizi di rete (server di vario genere, dalle mailing list ai fileserver ai siti web ecc.) dei nascenti server comunitari, mantenere un utente "luther/luther". Ancora oggi non mi stupirebbe incappare in servizi accessibili con quell'utente e quella password considerate "standard" dalle creature simili cresciute nell'affinità con hackmeeting e dintorni.
Perciò: lasciate stare Luther Blissett. Questa "operazione culturale" ipnocratica non ha nulla a che vedere con quella storia. Ultimo ma non meno importante perché ci offre invece l'occasione per una considerazione chiara: chiunque, oggi, faccia ricorso a LLM gestiti da multinazionali avide, contribuisce in maniera non irrilevante all'aumento esponenziale di consumi energetici, nonché all'emissione di CO2 per calcolare le "risposte" alle proprie "domande".
Ovunque nel mondo i giornali e le case editrici, grandi e piccole, stanno licenziando e sostituendo gli umani con servizi LLM, per sfornare sbobinature, copertine, quarte di copertine, comunicati, newsletter, email, comunicazioni, progetti editoriali, traduzioni, promo audio, video, e via dicendo. Illusione non pia, quella della sostituzione dell'umano tramite l'automazione industriale. Illusione rapace e avida di profitti, incurante della qualità di testi, immagini, audio, video e comunque delinquenziale per via dello smodato consumo energetico necessario per questa "sostituzione". Ma non si può automatizzare l'umano, perché l'automazione è una storia di meraviglia nei confronti di ciò che si muove per moto proprio, pervertita allo scopo di produrre più merci inutili e nocive. Ma questa è un'altra storia: un'altra volta.
A me personalmente piacciono le macchine. Non tutte però. Anzi, trovo insulse la maggior parte di quelle che ci circondano oggi, anche nell'industria culturale. Infatti le macchine non sono tutte uguali. Le macchine dei padroni fanno gli interessi dei padroni. Le macchine evolute per servire i padroni serviranno i padroni. Vanno disertate e abolite. Questo è chiarissimo ed evidente al di là di ogni ragionevole dubbio per tutto ciò che va sotto l'assurda, antropomorfizzante etichetta di "Intelligenza Artificiale" stile GPT. Di fronte a continue catastrofi climatiche e sociali, gli investimenti sono stati spostati dai social media e dalle cripto-idiozie alle IA. Siamo in balia di libertariani sociopatici che bramano di andare su Marte e per farlo sono disposti a bruciare la Terra intera con gli umani che la abitano, per non parlare delle altre specie viventi. No, non si può "usare bene" l'IA perché è una tecnologia industriale, ovvero una tecnologia strutturalmente affetta da controproduttività e che produce nocività, al contrario di tecnologie conviviali pensate ed evolute dalle persone per le persone nei loro ambienti di vita.
Pensateci, la prossima volta che vi troverete di fronte a un "prompt generativo". Certo, non dipende solo da voi. Non avete scelto voi l'icona su WhatsApp dell'IA di Meta; né i risultati generati dall'IA di Google, ecc ecc ecc.
Però potete decidere di disertare. Anche perché è robaccia. Meglio stroncarla. Senza appello.